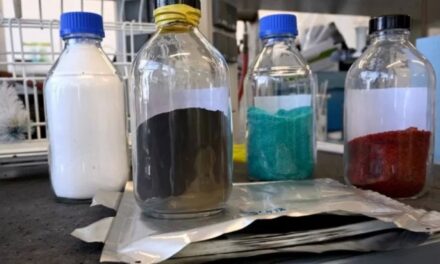Anche grazie a foto furbe, il Po nei giornali è dato per morto, ma andrò a vederlo con i miei occhi. Ci vado in macchina, anche se avrei voluto andare di passaggio in passaggio come G. Celati, ma ormai nessuno ti prende per strada gratuitamente. Mangio in una trattoria a Caorso davanti un’ansa piena di alberi e aironi cenerini; il Po si presenta come una donna in perfetta salute, di cui mi innamoro. Il ristoratore è uno degli ultimi pescatori che pesca e cucina i pesci del fiume, come suo padre e suo nonno. Mi mostra le foto della piena del 2000, i fogli incorniciati dei premi culinari sono rimasti accartocciati da quel giorno, e le foto dello storione gigante catturato dal padre: mi confida che quando lo si prendeva era festa in tutto il paese.
Arrivo alla diga di Isola Serafini, dove l’Enel produce energia idroelettrica. A monte ci sono venti metri d’acqua, a valle sembra di stare ne La Terra Desolata di T.S. Eliot: “Qui non c’è acqua, ma soltanto roccia… i piedi nella sabbia… la montagna dai denti cariati che non può più sputare… il tuono secco senza pioggia“. L’acqua comunque scorre, non è solo sabbia, in quattro giorni da qui arriverà al mare, eppure, è poca. Le montagne non hanno ricevuto abbastanza neve in inverno e ora non rilasciano tanta acqua.
Si stagliano oltre l’orizzonte piatto i torroni delle industrie, i campanili e gli acquedotti, ma è soprattutto l’ex centrale nucleare di Caorso a ergersi a totem. Rimasta attiva per tre anni, è stata dismessa appena dopo Cernobyl e la stanno ancora smantellando. Chi ci vive attorno ha strane teorie, dice che paghino da trent’anni duecento operai per far nulla, o che sia segretamente usata per scopi militari. Chiedo al guardiano dell’area protetta cosa stiano facendo, mi risponde: “Stanno smantellando”, ma ormai, condizionato dalla gente di lì, non posso crederci più di tanto.
Nella bassa piacentina ci sono i campi di pomodori, mais, frutta, soia; nelle golene, oltre l’argine, i tipici pioppeti. In un circolo di Monticelli il proprietario mi offre salame e lambrusco di mattina che invano provo a rifiutare. Quando parla di Torino, indica a monte, di Ferrara a valle, il Po connette i luoghi come la Via della Seta. È laureato in Agraria, mi spiega che bisognerebbe irrigare a goccia invece che per allagamento per evitare lo spreco. I suoi nonni con la stessa acqua lavavano la verdura raccolta e annaffiavano le piante; le precedenti generazioni hanno vissuto dando per scontato l’acqua, eppure non ne abusavano.
A Spinadesco un uomo della Protezione Civile mi racconta di come i giovani abbiano abbandonato il fiume e la vita pratica, mentre mi indica germani che volano in coppia, interrompendosi da solo più volte, rapito dalla magia della fauna selvatica. Ha scoperto dei ragazzi inquinare dalle telecamere per i lupi e li riporterà qui per trasmettere a loro il rispetto. La guerra, il virus e la magra provocano in lui un malessere apocalittico, ma reale: “Se succede qualcosa, in paese sono l’unico punto di riferimento per la sopravvivenza”.
Lungo la bassa parmense si notano impianti di biogas con cupole verdi o bianche che funzionano a mais. Il mais di secondo raccolto appare secco, per la siccità le falde acquifere si sono abbassate e ci sono stati razionamenti d’acqua ma non drastici. Sono andati persi dei raccolti che necessitano di grande apporto di acqua, come i fagioli. A Zibello visito il Cinematografo del sig. Narducci, un museo del cinema da lui creato che ha iniziato da piccolo con suo fratello proiettando film ai contadini nei casali. Mi mostra la bici usata per trasportare di corsa le pellicole nel tempo tra il primo e il secondo tempo in due cinema a sei chilometri di distanza che usavano le stesse pizze del film per risparmiare. La lotta allo spreco richiede fatica.
Incontro esperti del fiume, il Po è una catena, unisce persone molto diverse che ti dicono sempre da chi andare successivamente. Prima un giornalista e fotografo di Zibello, che si firma “Eremita del Po”, che indovina la misura delle piene osservando l’altezza delle lumache sugli alberi. Poi, V. Daolio, creatore dell’Acquario del Po a Motta Baluffi. Grazie a lui scopro del ‘sacco di sabbia’, massiccio dragaggio abusivo del fondale del Po compiuto da mafie e imprese nei decenni scorsi, prima dell’apposita legge che contrasta il fenomeno. La fine sabbia del Po, perfetta per costruire case e strade, formata dall’erosione della roccia in migliaia di anni, è stata prelevata in poco tempo. “Anche per questo motivo il Po è diventato un torrente”, ammette Daolio. Poi il Comandante Landini della Stradivari, una bellissima motonave turistica che aspetta che l’acqua si rialzi per ripartire. Mi racconta energicamente della Resistenza, quando i partigiani sgozzavano i tedeschi mentre li trasportavano in barca da una riva all’altra: “Il corpo con un taglio si riempie d’acqua e scompare nel fondale”. A Guastalla conosco un ex pescatore di siluri, ideatore di un locale sul fiume pieno di artigianato fatto da lui utilizzando la legna del fiume: all’ingresso ha intagliato una radice e ne ha fatto il volto di Medusa piena di serpenti. Mi dice che c’è un rimpallo kafkiano tra Regioni, Province, Comuni, Aipo, Consorzi di Bonifica, Enel e molte idee di rinnovamento si arenano nella burocrazia.
Con loro parlo (anzi ascolto, uno di loro mi ha detto giustamente: “Non parlare del fiume, tu non sai niente del fiume”) di progetti di sistemazione fluviale per preservare migliaia di metri cubi di acqua. Ad esempio, la “bacinizzazione”, concepita negli anni ’60, quando il fiume veniva usato come via di commercio, che vorrebbe cinque o sei sbarramenti dalla diga Serafini fino alla foce per controllare il livello dell’acqua e produrne energia. Oppure ci sono le proposte che lo lascerebbero a corrente libera: riportarlo al suo alveo originale, distruggendo alcuni pennelli; valorizzare le lanche, i rami morti del fiume, che sono bacini naturali; scavare le golene, per ricavarne altri. Ognuna ha una visione politica diversa, ma tutte mettono al primo posto l’ecosistema del fiume. Viene fuori spesso il paragone con Israele. Spreca poco, desalinizza l’acqua del mare, addirittura ne ricava dalla condensa atmosferica grazie a dei generatori: c’è bisogno di prendere esempio da chi già convive con la desertificazione. Si lamentano che in Italia si fanno le cose con poca lungimiranza. A Boretto non si può non notare il porto turistico mai utilizzato, un’orrenda piattaforma di cemento che si affaccia sul fiume. È difficile pensare che sia stato concepito senza la meschinità di arricchire qualcuno.
Il fiume da dentro è uno specchio, doppio è il tramonto, doppi i cefali argentati che saltano. Andando veloci in barca, si diventa tutt’uno col vento. Ricorderò sempre un barcaiolo che mi ha spiegato: “Dove l’acqua oscilla velocemente, si dice che l’onda ride, attento, perché lì dietro si nasconde una secca”. Sopra il pelo dell’acqua spunta lo splendido battello Ferrante-Gonzaga del ‘500 riverso a pancia in su. Inchiodato a mano con eliche di bronzo, affondato per la piena del 2000 e riemerso quest’anno, è simbolo di un’Europa di casate nobili. Si pensa che quest’anno emergano reperti per la secca, ma la gente rivierasca ci è abituata, soprattutto dopo le piene o in estate, il Po fa emergere il suo Eldorado. Sotto ci sono olmi medievali, palafitte dell’età del bronzo, carrarmati, mura di chiese seicentesche, ossa dei greci antichi che lo hanno navigato. Al Museo del Po di San Daniele Po ci sono il femore di un elefante antico e il teschio di un rinoceronte, che hanno abitato la valle in altre ere geologiche.
Conosco il signor Gialdini, l’ultimo pontiere, che ha creato un museo sul ponte di barche di Boretto. Il ponte di barche è un ponte che galleggia sull’acqua, formato da barche collegate l’una all’altra. Nel ’62 è iniziata la costruzione dell’attuale ponte sospeso di Boretto e quello di barche è stato dismesso nel ’67. Mi spiega che il pontiere è un lavoro faticoso, soprattutto quando si doveva sgottare (svuotare dall’acqua) le barche con una pala, oppure quando si doveva aprire il ponte per far passare una imbarcazione e poi richiuderlo tirando delle corde. Parlando di Zavattini, il quale aveva installato una balera sulla spiaggia di fronte al ponte di barche per girare una scena di un film, dice: “Mariti e mogli ricordano di essersi conosciuti quando facevano le comparse quel giorno”.
A Gualtieri, il signor Galeffi della Casa Museo A. Ligabue mi presenta un suo compaesano di oltre ottanta anni che ha conosciuto A. Ligabue. Mentre descrive come il pittore, isolato nei boschi in golena, si trasformava in un’aquila per dipingerla indossando una protuberanza a mo’ di becco, ululando e scuotendo le braccia, si alza di scatto ed esclama: “Devo andare a vedere come sta il Po”. In un attimo è lontano con la bici. I suoi amici normalizzano: “Fa così ogni due ore, da tutta la vita”. Uomini come lui non chiedono niente oltre ciò che il fiume già dà: la legna, la vista, gli animali. Temono le sue ribellioni, ma le rispettano. Lo curano con devozione, si rapportano al Po come a una forza soprannaturale. Vengo consigliato di andare a “Montecitorio”, una postazione con vista magnifica, chiamato così perché si fanno discorsi politici, ma quando arrivo è vuoto, c’è solo un giornale locale. In prima pagina si ripercorrono le radici mitiche del Po, anticamente chiamato Eridano, in cui Zeus fece precipitare e morire Fetonte che guidava il carro del sole a sproposito. Lo piansero le numerose lacrime delle Eliadi, trasformate in ambra e a loro volta in pioppi.
Tra il reggiano e il ferrarese arriva aglio, cipolla, mele, poi ancora mais, soia, erba medica. Ci sono case diroccate, alcuni paesi sembrano disabitati. I pochi cinema che trovo proiettano blockbuster americani, oltre non vanno. Sull’insegna di uno dei lidi sul Po, con bar e ristorante, c’è la foto di una spiaggia trasparente della Sardegna; un cartellone di una sagra paesana riporta la piana delle mongolfiere della Cappadocia; a Ostiglia i due palazzi di dieci piani vengono chiamati i “Grattacieli”. Le foto e i termini richiamano l’altrove per creare attrattiva. È strano, perché la provincia spesso crea tradizioni più autentiche e particolari della grande città. Si fa strada in me la consapevolezza di un’altra desertificazione, quella culturale dei territori interni. Se imperversa il mito di andarsene verso la città, si svuotano questi luoghi della loro importanza.
A Bondeno visito una famiglia contadina, fanno vendita diretta. Sul perimetro hanno piantato una striscia di bosco, mi spiegano che protegge dai venti gelidi e abbassa la temperatura d’estate, ma pochi lo fanno perché coltivano fino all’ultimo centimetro. Nessuno di loro è andato a vedere il Po quest’estate, “altrimenti ci verrebbe un infarto”. Hanno una biodiversità e differenziando le coltivazioni sono coperti da rischi, perché le piante agiscono in modo diverso: “La natura non fa nulla per caso”, mi rivela il figlio. Mi dice che le mietitrebbie delle grandi aziende hanno bracci di 20 metri. Nei campi nidificano animali di piccola taglia e i cuccioli, che, non avendo il tempo di scappare, rimangono uccisi. Dovrebbero adottare dei dissuasori acustici, ma nessuno investe su ciò che non produce. Il padre anziano, con occhi azzurri fieri, mi parla della trasformazione del paesaggio: “Anni fa filari di pioppi delimitavano ogni appezzamento, rendevano fertile il terreno, ora non ci sono più… L’asfalto è ovunque, anche dove non serve”. Ci tiene che cerchi su internet cosa sia la conferenza di Bilderberg, in cui “i potenti si spartiscono il mondo” e mi chiedo quanta riflessione ci voglia per connettere Bilderberg a Bondeno.
Verso la foce, le rondini volano splendenti di colori. Le foglie marroni in pieno agosto cadono dagli alberi in anticipo sull’autunno; dietro una pianta verde, ce n’è una morta. Qui poiché il fiume è debole, è subentrato il mare con prepotenza e gli agricoltori dai pozzi limitrofi pescano acqua salata. Che fare, quindi? L’unica cosa, oltre a spendere soldi per cisterne, è sperare che piova.
Mi chiedo come mai il Po non sia presente nella Fontana dei Fiumi di Piazza Navona, eppure è vasto come il Gange, ricco come il Danubio, segreto come il Nilo, selvaggio come il Rio. È ostile e pericoloso, non di rado affiorano morti annegati. Anarchico, se qualcuno fa pesca di frodo o furti di motore di notte, è difficile coglierlo in flagrante. Ma anche inquinato da grandi industrie. Al fascino corrisponde un declino.
Dove sono finiti i giovani che un tempo giocavano sugli argini con i sassi o raccoglievano le viole? Si capisce che non lo amano più. I vecchi del Po, dalla loro, non credono in una rivoluzione, rimangono ad aspettare carichi di nostalgia e risentimento, non si sa bene che cosa. Ci vogliono mani silenziose per mantenere il fiume, ma di chi saranno? Che ne sarà dei suoi segreti? Tra ieri e domani, il Po oggi è un ponte di barche diviso in due metà che non si toccano, senza più pontieri a richiuderlo, in balia della corrente.
Giacomo Mazzariol
Nato a Castelfranco Veneto nel 1997, è autore di “Mio fratello rincorre i dinosauri”, diventato un film di Stefano Cipani, e “Gli squali”. Insieme al collettivo di sceneggiatori “Grams”, ha scritto la serie tv “Baby”, trasmessa da Netflix