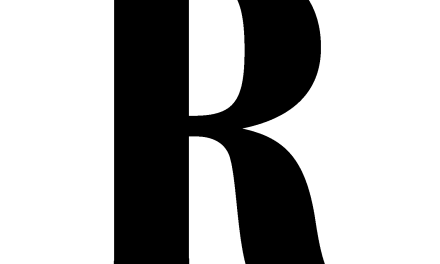Una batteria ad alghe sarebbe stata perfetta per un romanzo di Emilio Salgari, magari per alimentare un profondimetro o una lampada sottomarina. E invece alla University of Cambridge ne hanno sviluppata una per dare energia a un microprocessore Arm, con la prospettiva domani di fare lo stesso con un vero e proprio sensore internet-of-things. Sì, uno di quei piccoli dispositivi che in un appartamento consentono di controllare una tapparella, oppure comunicare all’aspirapolvere che siamo usciti e può iniziare le pulizie.
“Si chiama Synechocystis e oggi è classificato come un cianobatterio, ma fino a 20-30 anni fa era chiamata alga blu-verde, data la sua pigmentazione; biologicamente è simile a una pianta”, ci spiega Paolo Bombelli, uno dei ricercatori del team del Dipartimento di Biochimica dell’ateneo che ha seguito il progetto. “Ne abbiamo sfruttato le proprietà di fotosintesi per creare un piccolo sistema elettrochimico che, alimentato con la luce, produce corrente elettrica”.
Arm Research, che ha sede proprio a Cambridge, ha sviluppato il chip di test, costruito la scheda correlata e impostato l’interfaccia cloud di raccolta dati per gli esperimenti. Tutti i dettagli sono stati esplicitati nello studio Powering a microprocessor by photosyntesis recentemente pubblicato, dopo la consueta revisione, sulla rivista scientifica Energy&Environmental Science.

Come funziona la bio batteria
Una batteria ad alga come quella realizzata dal team di Cambridge è una potenziale risposta al problema dell’alimentazione dei dispositivi internet-of-things. Saranno più di un trilione nel mondo entro il 2035, secondo il noto produttore inglese di chip Arm. E di certo l’alimentazione non potrà essere gestita tramite miliardi di piccole batterie agli ioni di litio – un materiale sempre più richiesto anche a causa del boom delle auto elettriche e ibride.
Ecco spiegato il senso di un dispositivo fotosintetico, a ridotto impatto ambientale, capace di sfruttare costantemente la luce naturale oppure quella artificiale come fonte energetica. “Nello studio abbiamo confermato che la batteria ha funzionato sei mesi, ma in verità siamo riusciti ad alimentare il chip Arm Cortex M0+ per più di un anno e probabilmente avremmo potuto proseguire se non avessimo dovuto restituire il processore”, sottolinea Bombelli.

Nello specifico, la corrente generata doveva consentire al chip di eseguire un solo comando: ovvero confermare l’esecuzione di una semplice operazione aritmetica e in caso contrario – quindi mancanza di corrente – generare una notifica di errore. Il contatore ha raggiunto i 125 miliardi di operazioni in sei mesi e di fatto non si è mai fermato. La corrente prodotta variava durante l’intera giornata, ma ovviamente il picco veniva raggiunto nelle ore diurne. Durante le ore notturne comunque veniva assicurata una soglia minima grazie all’energia chimica accumulata in precedenza.
Ad aggiungere valore alla sperimentazione il fatto che sia avvenuta in ambiente domestico e dunque non-controllato come può essere in laboratorio. Ciò vuol dire che la batteria è stata esposta al naturale ciclo quotidiano di luce ed è stata soggetta alle variazioni di temperatura che si hanno in un ipotetico ambiente dove questa tecnologia potrebbe trovare applicazione.
I precedenti
La generazione di corrente tramite batteri non è una novità: le prime pile a combustibile microbiologico sono state sviluppate a partire dagli inizi del ‘900. In questi casi però si trattava di organismi alimentati con zuccheri o altri composti, mentre la sfida del team di Cambridge era quella di sfruttare la fotosintesi. Quindi trasformare la luce in sorgente energetica e poi convogliare la corrente verso un apparato capace di sfruttarla.
“Tutti gli organismi fotosintetici sono capaci di scomporre le molecole d’acqua grazie alla luce, generando ossigeno, elettroni e protoni. L’ossigeno viene rilasciato nell’aria; i protoni e gli elettroni con l’anidride carbonica formano nuovi zuccheri o altri prodotti. I nostri sistemi permettono di prendere alcuni di questi elettroni e incalanarli in un elettrodo per produrre corrente”, puntualizza il ricercatore.
Il passaggio di conduzione finale – attraverso un elettrodo – è stato l’oggetto di studio di questi ultimi dieci anni perché il trasporto nello spazio intracellulare ha rappresentato storicamente la sfida più ardua. Bisognava individuare un “trasportatore” adatto, uno sherpa che reggesse le difficoltà del percorso.
“Alla fine abbiamo scoperto che con un anodo in alluminio, il cianobatterio formava colonie attive e quindi un biofilm. E vi abbiamo abbinato un secondo elettrodo costituito da una lamina in carbonio e nanoparticelle di platino affinché funzionasse come catodo”, spiega Bombelli. “Il nostro trasportatore era frutto della combinazione dell’alluminio e i batteri che prolificano nella soluzione liquida”.

E così si è ottenuta una batteria con superfici trasparenti, che pesa solo 50 grammi, è alta 6 centimetri e contiene circa 14 ml di soluzione acquosa a base di Synechocystis. La tensione elettrica è di circa 700/800 millivolt, mentre l’intensità è di pochi microampere. Ovviamente una comune pila AA viaggia a 1,2 volt e dispone di più cariche elettriche, ma dopo un certo periodo esaurisce la sua capacità operativa. Una pila a cianobatterio può funzionare per più di un anno.
Un progetto dal futuro brillante
“Arm ci ha fornito un chip normalmente usato nel settore Internet-of-things adattando il voltaggio alla nostra pila, mentre adesso la nostra prossima sfida e di testare direttamente un sensore IoT di mercato, adattandoci noi alle sue esigenze tecniche”, dice il biochimico italiano. Il team sta pensando a piccoli visori, mini-display, che mostrano informazioni di vario tipo e hanno bisogno di soli 3 volt.
La prospettiva è di intervenire probabilmente sia sulle dimensioni della batteria che sulla ricerca di un cianobatterio più efficiente o comunque più adatto alla tipologia di sensore. Ad esempio ce ne sono alcuni in natura che resistono meglio alle alte temperature. “Poi sappiamo che il voltaggio non dipende dalla quantità di liquido, mentre l’intensità di corrente sì. Per incrementare il voltaggio bisognerà mettere più sistemi in serie montati vicini”, aggiunge Bombelli.
Le variabili in gioco sono tante così come le opzioni. “Noi abbiamo puntato sul Synechocystis che è stato isolato nel 1968 a Oakland sfruttando l’acqua di un lago del Nord America e che storicamente è il più diffuso nei laboratori, ma è solo il punto di partenza perché ciò che contava era scoprire il meccanismo per impiegare la corrente generata”.